 Il connubio tra filosofia e musica non è pio così insolito, e per spiegarlo sintetizzo le parole del prof. Elio Matassi durante un'intervista.
Il connubio tra filosofia e musica non è pio così insolito, e per spiegarlo sintetizzo le parole del prof. Elio Matassi durante un'intervista. In un celebre luogo del Fedone platone, durante un sogno sogno, Socrate dice a se stesso d’impegnarsi nel fare musica e nel comporre; la risposta che, a sua volta, Socrate dà a se stesso, sempre nell’ambito dello stesso sogno, è del tenore seguente: nella vita Socrate ha sempre perseguito la filosofia ed in tale perseguimento ha di fatto coltivato la musica stessa, perché che cos’è, al limite, la filosofia, se non una forma, la forma più elevata di musica? In ogni caso Platone evidenzia una subordinazione della musica alla filosofia.
Un’interpretazione “moderna” di tale rapporto di subordinazione è stata data da Schopenhauer: come musica, la filosofia rivela la propria essenza, è linguaggio che “dice” il mondo com’era prima della creazione, un tema che governa la filosofia di Schopenhauer e che rappresenta una costante di tutta la filosofia antica. Successive prospettive, insieme, producono una radicale conversione. Il suono non è più una cifra meramente speculare di un presunto universo cosmologico pienamente armonizzato, non è più un semplice messaggio astrale, ma diventa “materia umana per eccellenza”. La superiorità estetica del suono viene chiaramente fondata sull’effetto che esercita sulla nostra ricettività sentimentale: il suono non può non comprometterci sentimentalmente, compromissione che riesce anche, attraverso l’ascolto, a metterci in discussioLa figura centrale che esalta tale passaggio è quella del compositore definito non casualmente da Adorno stesso “dialettico”. Il compositore, infatti, proprio in sede compositiva riesce a risolvere la vexata quaestio del rapporto tra soggetto e oggetto, tra i quali esiste una interazione storicamente data e autenticamente cogente. Il compositore dialettico indica dunque concretamente la direzione della nuova sequenza: dalla musica alla filosofia. Non solo la musica non soggiace più al primato della filosofia, ma addirittura indica alla filosofia una via d’uscita da polarità che teoreticamente non erano mai riuscite a sciogliersi in maniera definitiva.
Un’interpretazione “moderna” di tale rapporto di subordinazione è stata data da Schopenhauer: come musica, la filosofia rivela la propria essenza, è linguaggio che “dice” il mondo com’era prima della creazione, un tema che governa la filosofia di Schopenhauer e che rappresenta una costante di tutta la filosofia antica. Successive prospettive, insieme, producono una radicale conversione. Il suono non è più una cifra meramente speculare di un presunto universo cosmologico pienamente armonizzato, non è più un semplice messaggio astrale, ma diventa “materia umana per eccellenza”. La superiorità estetica del suono viene chiaramente fondata sull’effetto che esercita sulla nostra ricettività sentimentale: il suono non può non comprometterci sentimentalmente, compromissione che riesce anche, attraverso l’ascolto, a metterci in discussioLa figura centrale che esalta tale passaggio è quella del compositore definito non casualmente da Adorno stesso “dialettico”. Il compositore, infatti, proprio in sede compositiva riesce a risolvere la vexata quaestio del rapporto tra soggetto e oggetto, tra i quali esiste una interazione storicamente data e autenticamente cogente. Il compositore dialettico indica dunque concretamente la direzione della nuova sequenza: dalla musica alla filosofia. Non solo la musica non soggiace più al primato della filosofia, ma addirittura indica alla filosofia una via d’uscita da polarità che teoreticamente non erano mai riuscite a sciogliersi in maniera definitiva.
La musica, al limite, non può considerarsi neppure un oggetto del pensiero, ma è la stessa filosofia a porsi, a declinarsi come musica, la particolare “musica della filosofia”; come mousikos, infatti, il filosofo è colui che intreccia le relazioni, che sta tutto nella koinonìa delle forme. Una prospettiva configurabile come quel particolare non-luogo che è il punto di conversione tra le figure e lo sfondo, fra l’essere e il non-essere.













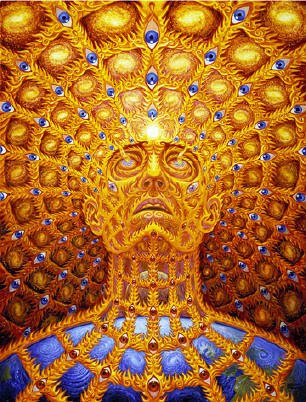











 uesto senso è impensabile secondo Curi estromettere dalla filosofia antica il Prometeo incatenato, o l'Antigone, l'Edipo re o il Trattato di Ippocrate relegandole nella categoria di "teatro"secondo una classificazione di biblioteconomia. Allo stesso modo come è possibile rendere esaustivo il discorso sulla filosofia italiana dell'800 senza parlare di Leopardi ostinandoci a ritenerlo solamente un poeta? E ancora perchè eliminare dalla storia della filosofia del XX sec. Kafka, Proust o T. Mann? La riabilitazione del mythos viene ricondotta anche alla Poetica di Aristotele conferendo a questo criterio la funzione di ribaltare il modo di costruire il pensiero filosofico che dunque non ricocnosce più solo al logos la capacità d'indagare sulla verità , ma finisce con il riconsegnare la filosofia ai suoi legittimi proprietari.
uesto senso è impensabile secondo Curi estromettere dalla filosofia antica il Prometeo incatenato, o l'Antigone, l'Edipo re o il Trattato di Ippocrate relegandole nella categoria di "teatro"secondo una classificazione di biblioteconomia. Allo stesso modo come è possibile rendere esaustivo il discorso sulla filosofia italiana dell'800 senza parlare di Leopardi ostinandoci a ritenerlo solamente un poeta? E ancora perchè eliminare dalla storia della filosofia del XX sec. Kafka, Proust o T. Mann? La riabilitazione del mythos viene ricondotta anche alla Poetica di Aristotele conferendo a questo criterio la funzione di ribaltare il modo di costruire il pensiero filosofico che dunque non ricocnosce più solo al logos la capacità d'indagare sulla verità , ma finisce con il riconsegnare la filosofia ai suoi legittimi proprietari.







